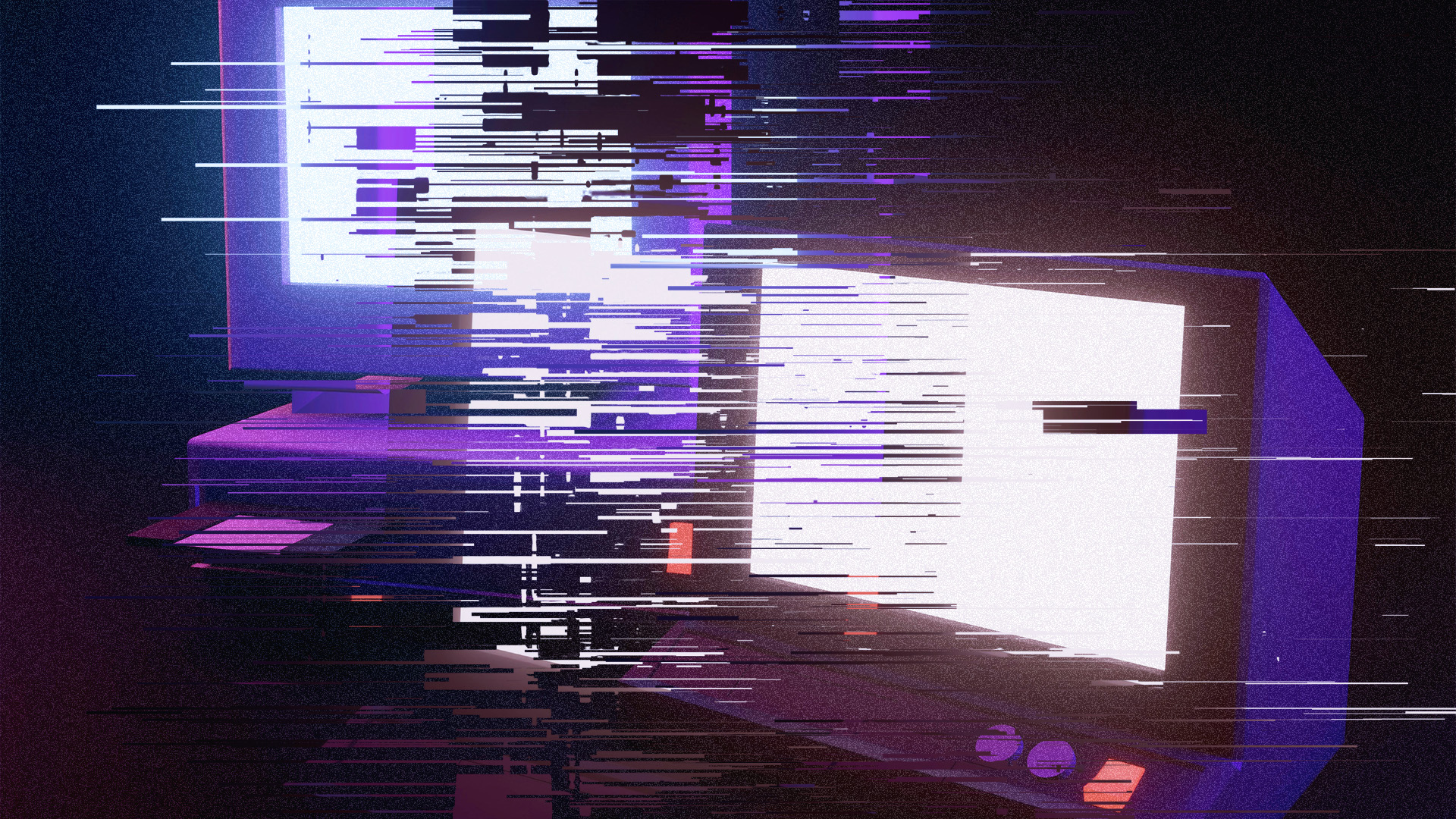PREMESSA: i contenuti che troverete partono dalle suggestioni espresse nell’articolo Arrivederci, ragazzi: quando gli adolescenti vogliono abbandonare Internet, pubblicato il 23/06/2025, sviluppati in Arrivederci, ragazzi: Tik Tok non abita più qui pubblicato il 07/07/2025 e in Arrivederci, ragazzi: Alice attraverso ChatGpt pubblicato il 21/07/2025
Quando sono partita con il “sezionamento” del sondaggio inglese intitolato Half of young people want to grow up in a world without Internet –per il quale, appunto, quasi la metà di un campione di adolescenti e giovani adulti britannici ha dichiarato di voler abbandonare la rete- mi sono concentrata su una “sfasatura” che era contenuta in diverse risposte e nelle relative analisi: quello che il campione indicava genericamente come Internet riguardava, in realtà, principalmente i social. I riferimenti all’ansia sociale, alla necessità performativa, alla dipendenza, non imputavano tanto l’ “autostrada”…ma chi la percorre, quell’autostrada. E se chi la percorre è peggiorato, dicevo, non è colpa dell’autostrada.
Continuo a pensarlo. Continuo a pensare che esista un problema culturale, o più specificamente educativo, rispetto alla questione; che molti parlino della rete senza cognizione di causa, senza aver chiaro cosa sia, come sia nata, cosa potrebbe essere, se fosse gestita con maggiore consapevolezza.
…Già, ma il punto è proprio questo: in gran parte la rete non è gestita con consapevolezza. O lo è, ma consapevolmente si sceglie di gestirla allontanandosi dai principi che l’hanno costruita. E se molti,ragazzi e non, arrivano addirittura a volersi “disintossicare” dal digitale (e al netto dei consueti allarmismi che questo tipo di notizie inevitabilmente porta co sè) è necessario ragionare anche su questo dato.
Forse, devo ammettere, io stessa mi faccio influenzare da cosa penso sia (ancora) internet. Anche io sono vittima dei miei bias. Osservando attraverso la lente -deformante- delle mie convinzioni, ho finito con l’ignorare l’elefante nella cristalleria. E quell’elefante si chiama Internet. Quello che è diventato, Internet. Un elefante cresciuto troppo, cresciuto male, spesso impasticcato.
Un elefante, per alcuni, già morto.
Internet è morto e neanche io mi sento troppo bene (semicit di semicit)
Internet è morto tra il 2016 e 2017, quando un esercito di AI scarica uno tsunami di fake sul web spodestando gli utenti “reali”. I contenuti online da quel momento sono tutti fasulli, nel quadro di un grande piano del governo (quale governo precisamente non si sa, dipende dal luogo in cui si discute della cosa, gli USA vanno per la maggiore comunque) per controllare la popolazione. In pratica, fine dell’internet delle persone, benvenuta era dei troll, dei deep fake, della propaganda.
Questa, sostanzialmente, la tesi nota come dead internet theory . Che, per la cronaca e se ci fosse bisogno di specificarlo, è una tesi priva di alcuna valenza scientifica: è semplicemente una stramba teoria del complotto partita da Reddit e circolata a sufficienza da risultare, per alcuni, credibile, se non addirittura vera.
Una bufala, insomma. Ma, come ogni bufala, una tesi che riflette di ansie profonde che riguardano il contesto in cui viviamo e la nostra difficoltà a comprenderlo, gestirlo, decodificarlo. Perché, se una enorme fetta di traffico della rete è effettivamente automatizzato e in mano a bot malevoli (ricordiamo che esistono anche quelli “buoni”, i chatbot) obiettivamente un problema da affrontare esiste.
E, in qualche modo, riflette aspetti della rete che, effettivamente, stanno prepotentemente modificandone l’assetto.
Chi non cerca, trova
Da alcuni anni gira in rete un un video di Yotobi (o meglio, della sua controparte Il Matthew del Tubo) che trovo interessante. Il titolo, decisamente esplicativo, è Il gioco dei video correlati: il content creator deve riuscire, attraverso la correlazione tra video suggeriti dalla piattaforma, ma poi scelti autonomamente, a collegare due contenuti apparentemente privi di nesso reciproco (ad esempio, Windows98 e la Sampdoria). Una sorta di metagioco, che sfrutta l’architettura della rete come occasione ludica: perché, in rete, tutto è collegato a qualsiasi altra cosa da alcuni gradi di separazione, basta solo trovare il percorso giusto per creare il nesso. Il passaggio da un link all’altro, da un click all’altro, impone all’utente un ruolo attivo, intellettuale e creativo. Impone curiosità e desiderio di scoperta. Chiunque abbia fatto ricerca online alla “vecchia maniera” lo sa benissimo.
Già, ma che differenza c’è tra la “vecchia maniera” e la “nuova maniera”? In un bell’articolo di Daniele Signorelli pubblicato il 3 giugno del 2025 da Link – Idee per la tv, intitolato Internet Senza Link, si sviscerano molto bene le caratteristiche dei nuovi modelli di ricerca online, modelli cosiddetti “conversazionali” e basati sulle AI generative. Sono pratiche che, come facilmente deducibile, non hanno nulla a che fare con la ricerca tramite link, poiché, com’è noto, in quel contesto è l’AI a fare la ricerca per l’utente. Il che, come si sottolinea nell’articolo e come avevamo sottolineato anche noi in precedenza, presenta un indubbio rischio informativo: le cosiddette “allucinazioni”, il mare di informazioni errate che sono date per buone e che come tali circolano.
Non solo: queste informazioni sono anche influenzate da bias cognitivi: Matteo Flora, recentemente, ha dimostrato molto concretamente come le AI generative si muovano su pregiudizi legati alla loro origine. Come? chiedendo a DeepSeek di parlare degli eventi di Piazza Tienanmen e ritrovandosi con un elegante invito del software cinese a parlare di altro.
Non si tratta, però, solo di autenticità. La tendenza agli “zero click” è legata anche alle logiche con cui i motori di ricerca stanno evolvendo, soprattutto quelli mainstream -che, naturalmente, sono i più utilizzati-. Google, ad esempio, ha introdotto i cosiddetti featured snippet, un’area in cima alla pagina di ricerca che offre un’anteprima delle risposte che stiamo cercando. Offrendoci la possibilità, in pratica, di bypassare completamente la ricerca. La ragione è estremamente prosaica: in questo modo, Google evita che il traffico si sposti sull’open web (l’utente non clicca, o finisce col cliccare su piattaforme comunque di proprietà di Google stessa) sfruttando a proprio beneficio contenuti creati originariamente da altri. Ancor peggio con AI Overview, arrivata in Italia lo scorso maggio: il Large Language Model di Google Search è in grado di svolgere ricerche anche complesse, che in passato avrebbero preteso visite a numerosi siti web. Ora-basta-solo-Google.
Da un lato, la costruzione di questo sistema disincentiva pesantemente la produzione di contenuti originali, visto che, tanto in termini economici, quanto di riconoscimento, il vantaggio è in mano alle “big”. Dall’altro, allontana sempre più fortemente dall’open web, costruendo una gigantesca filter bubble attorno ad una platea di utenti enorme.
Si tratta però anche di un problema cognitivo decisamente serio: l’utente si disabitua ad avere un ruolo attivo, in pratica, smette di “cercare”; contestualmente, abbassa il proprio senso critico e la capacità di approfondire e verificare; in ultimo, rinuncia all’aspetto creativo della ricerca tramite link, inibendo una funzione cerebrale fondamentale (ne abbiamo parlato nell’articolo citato sopra).
Il rischio è che internet diventi, per molti, un grande fast food informativo…in cui, a poco prezzo e senza sforzo, trovare quello che, paradossalmente, avevi già.
Un senso non ce l’ha
“Per anni abbiamo pensato che a uccidere internet sarebbero stati i bot, le macchine, le intelligenze artificiali. Era scritto nella dead internet theory, che sarebbe andata così: un giorno internet sarà popolata più da macchine che da esseri umani, i “contenuti” li produrranno più le macchine che gli esseri umani, sarà impossibile capire chi è cosa, chi sta parlando a chi, come e perché, il senso e lo scopo delle informazioni scambiate. Scopriamo oggi che la dead internet theory era sbagliata, almeno in parte: a uccidere internet non sono stati i bot ma gli italiani.”
Questa lunga citazione viene da un articolo dello scorso aprile di Rivista Studio, che riguarda uno dei fenomeni di Tik Tok (tanto per cambiare) di inizio 2025: gli Italian Brain Rot. Io ho una figlia, e posso capire benissimo cosa intenda l’autore Francesco Gerardi: la vera e propria invasione di mostri antropomorfi, dai corpi deformi e da nomi assurdi (Ballerina Cappuccina e Trallallero Trallallà, Tung Tung Tung Sahur e Trippi Troppi) amatissimi dai bambini e dilagati grazie a video virali conditi da sproloquio di voce rigorosamente sintetica (che, per la cronaca, è un prodotto di ElevenLabs, Adam). Un fenomeno che, per chi la rete la conosce da tanto, suona come una perversione senza precedenti.
Abbiamo già parlato di sludge content e AI stop. Bene, i Brain Rot sembrano portare all’ennesima potenza il livello di mancanza di senso (che, si badi bene, non è il nonsense) di molti contenuti che ormai dilagano sulla rete (ma anche in cartoleria, sotto forma di di figurine costosissime, album, edizioni speciali). Peccato, e il punto è nodale, che della loro origine non si conosca praticamente nulla (profili italiani, dicono, ma non si sa quali). Si sa solo che sono prodotti dell’AI.
Ma ogni Salieri ha il suo Mozart, e anche i Brain Rot sono destinati ad essere soppiantati da qualcosa di più fresco, pimpante, giovane. E napoletano, nello specifico. Di nuovo, su Tik Tok. Di nuovo, con contenuti senza senso. Di nuovo, con prodotti creati esclusivamente. Si tratta degli Skibidiboppy, video che hanno un’unica, evidentissima, mission: prendere in giro proprio i partenopei. Il core di questa serie (che poi ha dato vita ad un’infinità di spin off regionali, e figuriamoci se c’è un limite) è l’insulto. Il tutto, vale la pena sottolinearlo, nella banalizzazione, nella standardizzazione e nella leva sui più ovvi cliché razzisti.
Il cuore costruttivo è proprio la banalità. Gli Skibidiboppy sono la dimostrazione plastica di come il concetto stesso di “originale” rischi di perdere sempre più di valore.
La internet culture è finita?
Internet non nasce tanto -o solo- come una tecnologia: nasce soprattutto come un’idea. L’idea di uno spazio creativo libero e democratico, in cui la cultura non è appannaggio di pochi, in cui “sapere” è un diritto collettivo. Questo, sostanzialmente, intendevano i suoi creatori, Vint Cerf e Bob Kahn, quando affermavano “the internet is for everyone”. Anche se la cosiddetta internet culture o cyber culture ha un’origine sfuggente (c’è chi la fa risalire proprio a Cerf e Kahn, chi a William Gibson, che per primo ha introdotto il termine cyberspazio, chi a Touring…eccetera eccetera eccetera) la sua identità è forte e chiara e, almeno fino ad un certo punto, quasi romantica. L’idea che la “convergenza” in uno spazio digitale comune non sia solo una questione tecnologica e mediale, come nelle tesi -geniali e avveniristiche, intendiamoci- di Negroponte, ma anche, appunto, culturale, come nel pensiero di Jenkins, è profondamente legata al concetto di “cultura di internet”. Un’idea orizzontale, di scambio e confronto continuo.
Un’idea che, in qualche modo, ha cominciato, sottilmente, a vacillare con la nascita di spazi esclusivi ed escludenti: i social. Già, perchè, nel loro chiedere un’iscrizione, quegli ambienti smettevano di essere…for everyone. Contestualmente, con l’intervento di società sempre più potenti e di interessi sempre meno “comuni”, anche l’idea di una governance di internet multistakeholder, a cui tutti possono partecipare viene messa in crisi. In questa prospettiva, la disumanizzazione della relazione con la rete, tanto negli input (video inautentici, industriali, “sintetici”) quanto negli output (ricerche sempre meno “attive”) più che una “morte di Internet”, sembra mettere in discussione la cultura che ne sottintendeva l’esistenza.
Nell’introduzione di un libro pubblicato in onore dei trent’anni dalla prima connessione Italia-USA, intitolato Il futuro trent’anni fa si cita una frase di mio padre, Giorgio: “Internet ha i secoli contati”. Mio padre non era certo un fautore della dead Internet theory. Credo intendesse che Internet stava diventando qualcosa di molto, o meglio, troppo, diverso, dall’idea, profondamente intellettuale, con cui era stato concepito. Da uno spazio in cui trasmettere e condividere cultura ad un gigantesco territorio suddiviso in appezzamenti, feudi, potentati, alcuni strapieni di fertilizzanti. Non un’evoluzione, ma un’involuzione.
Più che la morte di Internet, il problema sembra essere questo. È la Internet culture, che sta morendo? Difficile dirlo, soprattutto perché, a decretarne la fine, ne sono convinta, non sarebbero tanto le big tech, i bot e nemmeno le AI…ma gli utenti. Sta a loro fare in modo che Internet, lo strumento che usano quotidianamente e a cui difficilmente, che lo dichiarino o meno, rinunceranno…sta a loro fare in modo che Internet mantenga il proprio ruolo culturale. Forse, la difficoltà di oggi potrebbe essere l’occasione per capire, una volta per tutte, che il fast food non si può consumare tutti i giorni. Che se si vogliono contenuti di qualità, bisogna difenderli. Può essere l’occasione di rinunciare alle informazioni “comode”, per quelle “nostre”. Che i contenuti a volte si possono e si devono pagare. Altrimenti, come diceva qualcuno, “se non paghi per un prodotto, il prodotto sei tu”. Non è un’utopia: se in Italia esiste Il post, è perché esistono gli abbonati de Il post. Se molti podcast vengono prodotti, se libri vengono scritti, se testi creati grazie al crowdfunding, vuol dire che c’è chi dà valore a contenuti di valore. Un meccanismo orizzontale e “dal basso”. Come l’Internet dei pionieri. Nessuno guadagna perché tutti guadagnino.
E questo esiste ancora.
E poi, come sosteneva Katlyn Tiffay su The Atlantic Internet non è morto proprio nella misura in cui possiamo continuare a leggere su Internet teorie assurde sulla sua morte. In fondo, anche quello è un momento di espressione orizzontale e “dal basso”. Due pilastri dell’internet culture.
E allora…Internet è morto. Viva Internet.
Anna Giunchi
(Executive Editor di «IO01 Umanesimo Tecnologico»)