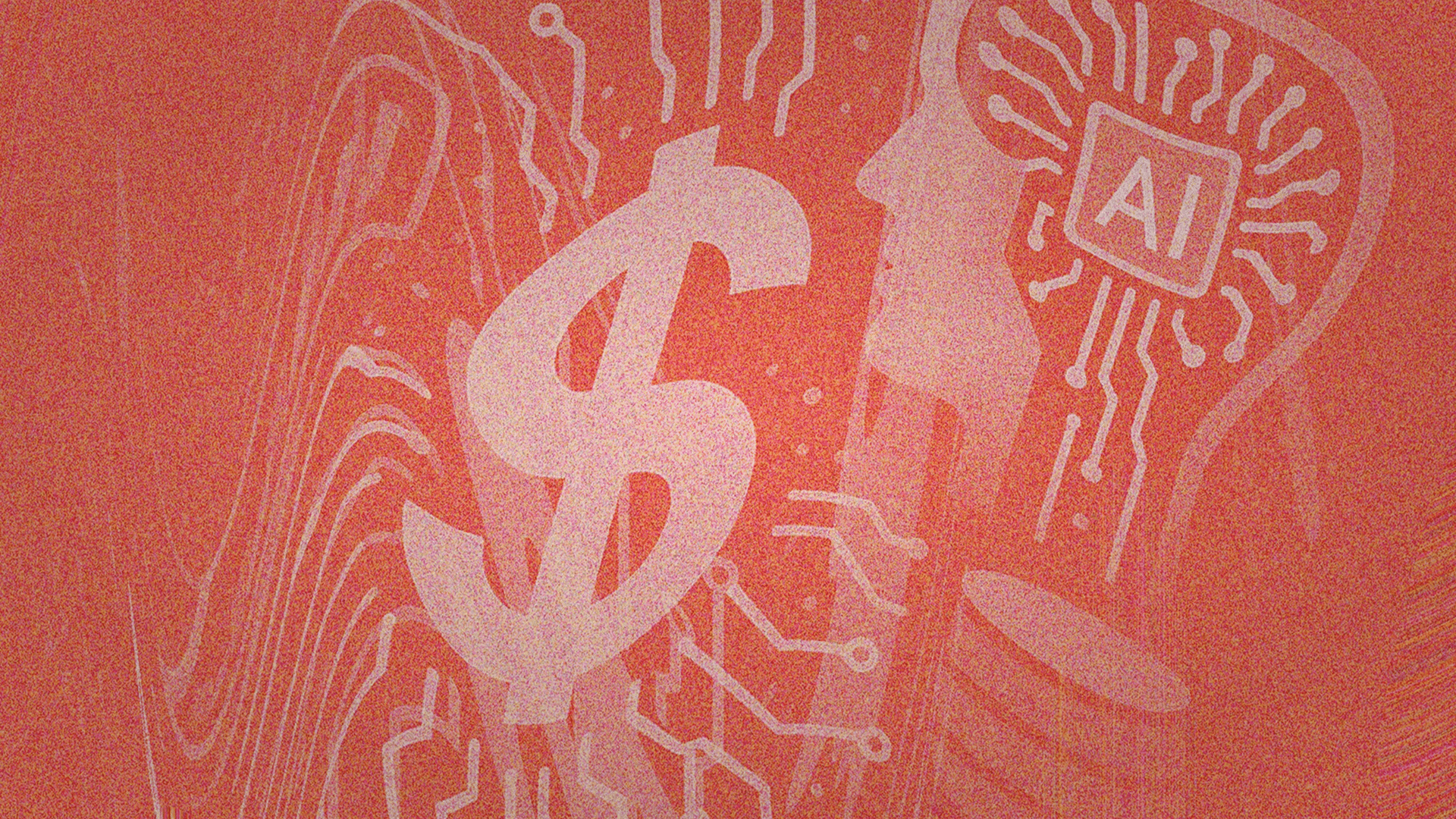Anche se non ne siamo pienamente consapevoli, un nuovo spettro si aggira nell’epoca contemporanea: lo spettro del capitalismo tecnologico. Per questo iniziare a comprendere il funzionamento delle nuove tecnologie che ci circondano e, soprattutto, interrogarsi consapevolmente sulle loro finalità è un’esigenza, anzi, un imperativo sociale. È questa urgenza a guidare la riflessione di Jathan Sadowski nel suo libro The Mechanic and the Luddite – A Ruthless Criticism of Technology and Capitalism (2020), in cui l’autore, docente alla Monash University di Melbourne e studioso delle dinamiche di potere legate all’innovazione tecnologica, propone una riflessione rigorosa e allo stesso tempo illuminante.
La tecnologia non è neutrale
Sadowski, in modo lucido e disilluso, parte da una “rivelazione”, che seppur banale non è scontata: la tecnologia non è neutrale, non è mai super partes. L’autore evidenza che ogni strumento, algoritmo o dispositivo digitale è il prodotto di scelte economiche, politiche e culturali che ne hanno garantito la nascita. Oggi la progettazione tecnologica riflette interessi specifici delle grandi potenze mondiali che, si potrebbe dire, riducono l’essere umano a un semplice consumatore fatto di dati da sfruttare invece che diritti da tutelare.
Nello specifico l’autore si sofferma sul ruolo emblematico dei venture capitalist: investitori privati che finanziano imprese in cambio di quote societarie, definiscono l’innovazione in base a ciò che si adatta ai rispettivi portafogli di investimento e allineano il progresso ai loro obiettivi di profitto. Lo studioso, quindi, mette in luce il fatto che in questo meccanismo la scelta e la definizione di ciò che viene sviluppato non segue l’interesse collettivo, ma logiche di profitto e speculazione finanziaria di pochi ma grandi investitori. Sadowski, per esempio, afferma che la Silicon Valley ha un ruolo fondamentale nell’orientare le aspettative pubbliche verso risultati che servono ai propri obiettivi, spesso invisibili ai cittadini.
Meccanici e luddisti: una doppia prospettiva necessaria?
Lo scrittore continua la sua disamina critica sulle nuove forme di capitalismo tecnologico delineando due figure simboliche: il meccanico e il luddista. Queste etichette personificano i diversi atteggiamenti e approcci nei confronti della tecnologia e il suo progresso. Per Sadowski il meccanico rappresenta chi conosce il funzionamento interno della tecnologia (chi sa smontare e comprendere macchine e algoritmi); il luddista, invece, sa interrogarsi sul “perché” della tecnologia, sulle motivazioni che hanno guidato la sua creazione e sui limiti etici della sua applicazione. Sulla base di questo ragionamento dialettico Sadowski cerca di arrivare ad una sintesi, dimostrando che solo la combinazione di queste due prospettive – competenza tecnica e consapevolezza critica – consentirebbe di esercitare un maggior controllo da parte della popolazione sul progresso tecnologico.
L’aspetto negativo dell’esistenza di persone poco consapevoli e critiche nei confronti degli scopi finali delle tecnologie viene individuato dall’autore in fenomeni inquietanti come l’AI Potemkin[1], denunciando l’illusione di massa riguardo l’esistenza di macchine autonome apparentemente indipendenti, che in realtà nascondono il lavoro umano di migliaia di operatori e programmatori (in carne ed ossa) spesso invisibili. Iniziare a riconoscere e sapere dell’esistenza di queste dinamiche è cruciale per progettare innovazioni etiche, morali e socialmente responsabili.
Dunque, il messaggio di Sadowski ci offre un forte stimolo di riflessione: cercare di essere un po ‘meccanici e un po’luddisti, oggi, significa prendersi cura del futuro della tecnologia, orientandosi verso libertà, benessere collettivo e partecipazione democratica.
Cercare di esercitare un discernimento dei meccanismi negativi che ruotano intorno al progresso tecnologico, non si tratta per forza di un rifiuto dell’innovazione, ma un atto di presa di responsabilità e consapevolezza. Solo così l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie digitali, che incutono timore e scetticismo nella maggior parte della popolazione, potranno diventare strumenti di emancipazione, piuttosto che di sfruttamento e controllo monopolizzato.
Sadowski, forse, ci mostra che la sfida non è evitare il progresso, ma ripensarlo, rendendolo etico, umano, ma soprattutto collettivo ed emancipato dagli interessi individuali. In questa prospettiva, la tecnologia diventa un’alleata per il raggiungimento di un “nuovo umanesimo”, in cui si possono realizzare nuove e migliori condizioni di lavoro, oltre che rafforzare le relazioni sociali e incoraggiare la conoscenza.
Da Sadowki al post-umanesimo fino a Pierre Huyge.
Tirando le somme, la riflessione di Sadowski in The Mechanic and the Luddite – A Ruthless Criticism of Technology and Capitalism (2020) non si limita ad una semplice denuncia fine a sé stessa. Al contrario, essa apre a una possibile prospettiva fiduciosa e costruttiva: le nuove tecnologie e le intelligenze artificiali, se liberate dalle logiche monopolistiche, capitalistiche e speculative, possono diventare delle alleate dell’umanesimo tecnologico.
In questo senso si potrebbe creare un parallelismo con la visione di Rosi Braidotti[2] filosofa italiana naturalizzata australiana. Nata in Italia, ha studiato in Australia e in Francia e lavora nei Paesi Bassi. Attualmente è Distinguished University Professor Emerita presso la Utrecht University, dove ha insegnato dal 1988. Braidotti, dopo aver constatato la fine dell’umanesimo, afferma che sia fondamentale aggiornare il modo di pensare alla relazione uomo-tecnologia tenendo conto dei cambiamenti in atto e senza abbandonarsi a catastrofi per un’umanità ormai perduta. Inoltre, la studiosa invita anche a cogliere le opportunità offerte dalle forme di neoumanesimo che scaturiscono dagli studi di genere, postcoloniali e dai movimenti ambientali.
Anche nel campo artistico la tensione tra uomo e tecnologie digitali è oggetto di indagine da parte di molti artisti. Si pensi ai lavori di Pierre Huyge, artista la cui ricerca è caratterizzata dalla costante indagine del rapporto tra l’umano e il non umano, andando a concepire le sue opere come forme di “mondi possibili”. In particolare, l’artista afferma che la finzione è per lui “mezzo per accedere al possibile o all’impossibile – a ciò che potrebbe o non potrebbe essere”.[3] Una mostra icastica dell’indagine di Pierre Huyge è stata sicuramente “Liminal” tenutasi a Punta della Dogana (Venezia) dal 17 marzo al 24 novembre del 2024. Durante questo periodo l’artista:
«[…] trasforma Punta della Dogana in uno spazio dinamico e sensibile in costante evoluzione. La mostra è una condizione transitoria popolata da creature umane e non umane, e diventa il luogo in cui si formano soggettività in perenne processo di apprendimento, trasformazione e ibridazione. Le loro memorie si amplificano grazie alle informazioni captate a partire da eventi, percettibili e impercettibili, che attraversano la mostra […] ».[3]
Prendendo spunto dalle opere di Huyghe, potremmo imparare a guardare con occhi nuovi il nostro rapporto con le tecnologie e le intelligenze artificiali. Infatti, come suggerisce l’artista, la relazione tra uomo e tecnologia si potrebbe concepire come una finzione, una costruzione, in cui umano e tecnologico collaborano in modo attivo per plasmare un nuovo mondo, una nuova forma di realtà ibrida. In questo senso, i nuovi dispositivi e i prodotti dei potenti algoritmi della IA possono essere interpretati come inedite forme di umanità, che al giorno d’oggi, forse, non è più etichettabile all’interno della sola sfera biologica e organica, ma anche in quella artificiale e tecnologica.
Sta a noi, quindi, scegliere quale prospettiva abbracciare: quella della paura verso una dipendenza o quella fiduciosa di una co-evoluzione tecnologica. Ovvero, riprendendo le parole di Jathan Sadowski, sta a noi capire in che punto ci vogliamo collocare tra la visione meccanica o luddista del mondo, senza dimenticarci che, spesso, in medio stat virtus (la virtù sta nel mezzo); perché’, alla fine, non dobbiamo per forza decidere per un futuro dominato dalle macchine o dall’uomo, ma è possibile un futuro che sia nelle mani di entrambi, in modo consapevole e collaborativo.