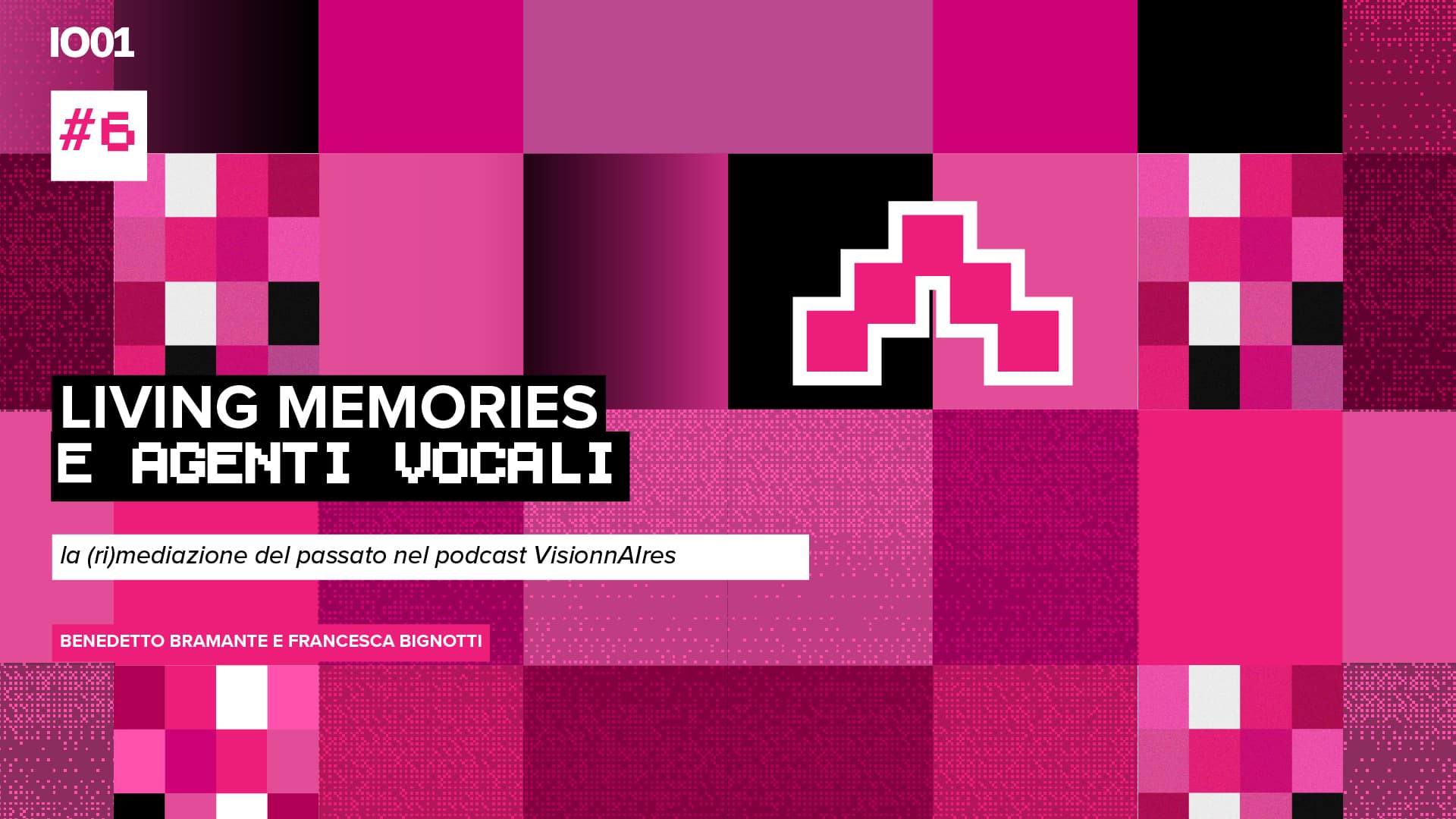Abstract
In che modo l’intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui ricordiamo? Il podcast VisionnAIres – Interviste (im)possibili, prodotto dall’Università Bocconi, propone dialoghi tra docenti e figure storiche “riattivate” attraverso voci sintetiche generate da AI. Questo articolo analizza criticamente il format come esempio di living memory algoritmica: una forma di narrazione vocale artificiale che media tra passato e presente, producendo nuove forme di memoria culturale. L’indagine, basata su un’analisi qualitativa di sei episodi, si concentra sul ruolo della voce sintetica come dispositivo performativo: non semplice replica tecnica, ma interfaccia affettiva e narrativa. I risultati evidenziano opportunità divulgative e limiti epistemologici: la costruzione dell’autenticità, la trasparenza sulle fonti e il rischio di attribuzioni improprie sono nodi cruciali nella rappresentazione di figure storiche tramite AI.
Keywords: Living Memories, AI, Patrimonio Culturale, Umanesimo Digitale, Voci Sintetiche
Introduzione
Cosa significa ricordare, oggi, in un tempo in cui la memoria non è più affidata solo ai racconti orali o agli archivi cartacei, ma anche ad algoritmi capaci di narrare ed esprimersi attraverso la dimensione vocale? Già nel 2011 Andrew Hoskins, nel suo saggio Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn [1], invitava a superare l’idea di una memoria come deposito statico, abbracciando invece una prospettiva dinamica e interconnessa. Nella svolta connettiva delineata da Hoskins, la memoria diventa un processo reticolare, distribuito tra soggetti, media e dispositivi digitali. Non è più semplicemente qualcosa che si conserva: è qualcosa che si ri-performa continuamente attraverso interfacce tecnologiche che ne ridefiniscono forme, tempi e attori.
Da sempre la memoria è al centro della riflessione nelle scienze sociali. La psicologia cognitiva, ad esempio, la descrive come un sistema dinamico influenzato dal contesto di recupero [2]; la sociologia ha mostrato come ogni atto del ricordare sia anche un gesto collettivo, situato e ritualizzato (si vedano, in particolare, Halbwachs [3] e Connerton [4]). Oggi questi concetti si innestano in una nuova ecologia mediale, in cui le tecnologie digitali non si limitano a registrare o archiviare il passato, ma ne diventano protesi mnestiche attive e capaci di generare, interpretare e trasmettere memorie. L’Intelligenza Artificiale, e in particolare i Large Language Models (LLM), rappresenta una delle metafore più potenti e controverse della memoria contemporanea. L’AI e le sue applicazioni non sono infatti oggetti monolitici analizzabili esclusivamente dal punto di vista tecnico, ma costituiscono una vera e propria costellazione di pratiche, infrastrutture e immaginari“[5] che attraversa linguaggi, poteri e visioni del mondo. Tra le sue applicazioni più suggestive vi è quella che tenta di “riportare in vita” figure del passato attraverso agenti conversazionali capaci di parlare, ricordare e raccontare. In concreto, chatbot e avatar vocali possono essere programmati per impersonare personaggi storici e interagire con gli utenti, offrendo l’illusione di un dialogo diretto con il passato. Queste living memories algoritmiche[6] trasformano la memoria in un’esperienza immersiva e interattiva, dove la voce sintetica funge da interfaccia tra epoche diverse.
La letteratura accademica su queste forme di memoria digitale incarnata è ancora agli albori. Fino a pochi anni fa, l’idea di conversare con una figura storica apparteneva alla fantascienza; oggi, gli strumenti di AI generativa offrono questa possibilità con un realismo crescente, attenuando la percezione della uncanny valley. Jones e Bergen[7] hanno recentemente dimostrato che GPT-4.5, istruito con prompt “personificati” per imitare figure storiche, è stato percepito come umano nel 73% dei casi in test conversazionali controllati. Analogamente, è stata recentemente evidenziata[8] la capacità di modelli come GPT-3.5 e GPT-4 di generare contenuti coerenti con specifici profili di personalità, secondo il modello del Big Five. Queste evidenze suggeriscono che interagire con un agente AI “storico” possa risultare sempre meno estraniante per gli utenti. Risulta quindi plausibile ipotizzare come l’accettazione delle living memories vocali vari in base a fattori culturali: ad esempio, distanza dal potere, evitamento dell’incertezza e orientamento individualista/collettivista influenzano la fiducia verso una voce artificiale che impersona un’autorità del passato. Tali tecnologie vocali, in ogni caso, non sono mai neutrali: incarnano valori e norme che ne condizionano l’uso, la regolamentazione e il significato pubblico.
Alla luce di questi sviluppi, il presente studio propone un’analisi critica del podcast VisionnAIres – Interviste (im)possibili, interrogandosi su cosa comporti restituire la memoria pubblica attraverso la voce sintetica. In particolare, la ricerca esplora quale tipo di memoria culturale venga costruita da queste interviste impossibili: sono memorie commemorative, educative, celebrative? Quanto risultano attendibili dal punto di vista storico? E quali immaginari attivano nell’ascoltatore?
Al centro dell’analisi vi è un elemento spesso sottovalutato ma cruciale: la voce sintetica come interfaccia della memoria culturale. Questo medium sonoro – al contempo dispositivo affettivo e simbolico– evoca presenza, costruisce fiducia, genera empatia e autorizza narrazioni. In un’epoca in cui le voci del passato ci parlano con timbri postumani, ricordare diventa anche un gesto politico: significa decidere chi parla (cioè chi seleziona e filtra il patrimonio di conoscenze da tramandare), in che modo e per quale destinatario. L’obiettivo di questo lavoro è quindi offrire una riflessione critica sia sul potenziale sia sui limiti della voce AI nella rappresentazione del passato, sempre nel rispetto dell’autonomia interpretativa di chi ascolta.
Metodologia
Il podcast VisionnAIres – Interviste (im)possibili è stato scelto come caso di studio per diverse ragioni. Innanzitutto, esso rientra in un più ampio progetto dell’Università Bocconi dedicato all’AI[9], presentato in occasione dell’AI Week milanese (febbraio 2025) e culminato proprio nel lancio della piattaforma interattiva VisionnAIres – The A.I. Generation. In questo contesto, il podcast omonimo nasce con finalità divulgative, come ponte tra il mondo della ricerca e il grande pubblico, coinvolgendo docenti di diverse discipline in dialoghi con grandi figure del passato.
Per analizzare VisionnAIres è stata adottata una metodologia qualitativa, strutturando una griglia di osservazione ispirata alle indicazioni teoriche emerse in letteratura sulla memoria culturale digitale, sulla socio-semiotica della voce sintetica e sull’etica comunicativa degli agenti AI. In particolare, sono stati presi in esame tutti i sei episodi disponibili sulle piattaforme di streaming audio, nei quali altrettanti professori dell’Università Bocconi conversano con personaggi storici generati dall’AI. Gli episodi analizzati sono: Riccardo Zecchina–Isaac Asimov; Gianmario Verona–Henry Ford; Oreste Pollicino–Niccolò Machiavelli; Francesca Buffa–Marie Curie; Massimo Magni–Sherlock Holmes; Francesco Perrini–Charles Darwin. Ciascun episodio, della durata variabile (circa 6–30 minuti), è stato ascoltato e interpretato focalizzando l’attenzione su quattro dimensioni chiave:
Comunicativa-rappresentazionale: la costruzione narrativa dell’intervista, lo stile dialogico, il registro linguistico e il tone of voice adottato dall’agente AI;
Socio-culturale: i riferimenti storici e culturali emersi nella conversazione, la relazione tra il contesto originario del personaggio e le tematiche contemporanee discusse;
Tecnologica: il ruolo della tecnologia sia come tema discusso nell’intervista (ad esempio, opinioni dei personaggi storici sull’AI) sia come elemento mediale del format (performance e caratteristiche della voce sintetica stessa);
Etico-critica: le questioni valoriali sollevate (ad esempio, implicazioni morali, sociali o deontologiche nelle risposte dell’AI) e una valutazione critica di accuratezza storica e responsabilità comunicativa.
Per ogni episodio si è proceduto a trascrivere e sintetizzare i contenuti salienti secondo queste categorie analitiche, in modo da consentire un confronto sistematico. L’approccio qualitativo, di tipo interpretativo, mira a individuare pattern ricorrenti e peculiarità narrative in ciascun dialogo, senza pretendere esaustività, data la natura esplorativa dello studio. Tuttavia, la griglia adottata garantisce replicabilità: altri ricercatori possono applicarla ad analoghi contenuti audio per valutare coerenze e differenze nelle modalità di living memory mediate dall’AI.
| Dimensione | Descrizione operativa | Indicatori |
| Comunicativa-
rappresentazionale |
Costruzione narrativa e tono del personaggio Al | Stile, lessico, uso prima persona |
| Socio-culturale | Collegamento tra epoca storica e temi attuali | Temi discussi, analogie presenti-passato |
| Tecnologica | Ruolo della voce sintetica e riflessioni sull’Al | Realismo vocale, uncanny effect |
| Etico-critica | Accuratezza storica e implicazioni valoriali | Errori, omissioni, messaggi impliciti |
Tab. 1: Schema delle quattro dimensioni analitiche impiegate per l’interpretazione qualitativa degli episodi del podcast, con descrizione operativa e indicatori osservabili.
Risultati
Prima di illustrare i risultati dell’analisi, è importante notare, come premessa, che in nessun episodio vengono forniti dettagli espliciti sulle fonti utilizzate per “addestrare” o impostare le voci AI dei personaggi storici. Si presume che i dialoghi siano stati modellati sulle opere e biografie dei personaggi, ma la mancanza di trasparenza al riguardo costituisce di per sé un primo dato rilevante. Ciò implica che l’ascoltatore deve affidarsi alla verosimiglianza percepita della voce sintetica per ritenere credibile il personaggio, senza poter verificare su quali basi testuali l’AI abbia costruito quella memoria vivente.
Dal punto di vista comunicativo e rappresentazionale, tutti gli episodi seguono un formato di intervista simulata in cui il docente contemporaneo riveste il ruolo di intervistatore e l’agente AI risponde nelle vesti del personaggio storico. Il registro è generalmente colloquiale e accessibile; l’AI adotta la prima persona e spesso fa riferimento ad esperienze della propria “vita” passata, creando l’illusione di un racconto in prima persona da parte del personaggio storico in formato AI. Ad esempio, nell’episodio Machiavelli–Pollicino la voce AI dell’autore de Il Principe impiega un linguaggio vagamente arcaico ma comprensibile, richiamando concetti chiave del suo pensiero (virtù politica, adattamento ai tempi) anche mentre discute di algoritmi e democrazia; analogamente, nel dialogo con Riccardo Zecchina, l’AI-Asimov mantiene uno stile immaginativo e divulgativo, arrivando a citare le sue Tre Leggi della Robotica quando si parla di regole etiche per l’AI. Questi accorgimenti comunicativi rendono le interviste coinvolgenti e aiutano a sospendere l’incredulità: la voce artificiale, pur non essendo identica a quella autentica (di cui peraltro non sempre esistono registrazioni), si presenta con un timbro e una prosodia adeguati a evocare la figura storica in questione.
Sul piano socio-culturale, ogni conversazione mette in relazione diretta il passato con problematiche attuali, evidenziando un intento divulgativo ed educativo. Ciascun personaggio viene interpellato su temi contemporanei affini alla propria sfera di competenza, instaurando un parallelismo tra la loro epoca e la nostra. Per esempio, Henry Ford dialoga con Gianmario Verona sulle sfide dell’intelligenza artificiale nell’industria moderna, paragonando l’impatto dell’AI a quello della catena di montaggio nel Ventesimo secolo; Niccolò Machiavelli viene coinvolto in una discussione sulla governance algoritmica, esplorando con Oreste Pollicino le implicazioni dell’AI per le istituzioni democratiche, alla luce del suo realismo politico rinascimentale; Marie Curie, conversando con Francesca Buffa, riflette sull’accelerazione che l’AI potrebbe imprimere alla ricerca scientifica e medica, rievocando al contempo le proprie scoperte nel campo della radioattività. Questi scenari offrono al pubblico chiavi di lettura originali: da un lato si omaggia l’eredità intellettuale di figure note, dall’altro la si attualizza, inserendola nel dibattito socio-culturale odierno su tecnologia, etica, economia e scienza.
Per quanto riguarda la dimensione tecnologica, essa si manifesta sia come oggetto di discussione interna ai dialoghi che come aspetto esperienziale per l’utente. Molti episodi affrontano esplicitamente il tema dell’innovazione tecnologica: Asimov conversa di intelligenza artificiale e di futuro dell’umanità, Ford di automazione e nuovi processi produttivi, Machiavelli di regolamentazione delle piattaforme digitali, Darwin di sostenibilità ambientale in epoca di tecnologie avanzate. In ciascuna di queste interviste impossibili, l’AI storico esprime opinioni informate su concetti che vanno oltre la sua conoscenza originaria, suggerendo che il modello abbia integrato dati e contesti successivi alla vita reale del personaggio. Ad esempio, Charles Darwin, uomo dell’Ottocento, discute con Francesco Perrini della blue economy (economia sostenibile degli oceani), concetto sviluppato solo in tempi recenti: ciò è reso possibile perché l’AI che lo impersona attinge a informazioni contemporanee, pur mantenendo un punto di vista evoluzionista in linea con il pensiero darwiniano. Va notato che l’illusione funziona, in gran parte, perché la qualità della sintesi vocale è sufficientemente avanzata da evitare effetti di spaesamento: le voci sono credibili, con intonazione naturale e tempi di risposta adeguati, segno di un’attenta calibrazione tecnica.
Infine, sotto il profilo etico-critico, emergono sia tematiche etiche discusse dai personaggi che questioni meta-narrative che il format stesso pone implicitamente. Gli argomenti trattati spesso includono riflessioni morali: Machiavelli e Pollicino ragionano sull’etica dell’intelligenza artificiale nel governo della società, toccando la necessità di regole e responsabilità; Asimov con Zecchina dibatte dilemmi sui limiti dell’AI e sul rapporto tra creatività umana e machine learning; Curie con Buffa accenna alla dimensione etica della ricerca scientifica aumentata dall’AI, come il bilanciamento tra progresso e sicurezza. Parallelamente, però, la nostra analisi solleva interrogativi etici sulla rappresentazione stessa di queste figure storiche via AI. Senza una esplicitata curatela dei contenuti generati, c’è il rischio che vengano attribuiti ai personaggi pensieri semplificati o inesatti, potenzialmente fuorvianti dal punto di vista storiografico. Ad esempio, se l’AI facesse pronunciare a una figura storica concetti antitetici al suo pensiero documentato (cosa che non accade nel caso studio qui analizzato, si ricorda) o affermazioni scientificamente imprecise, il patto comunicativo con l’ascoltatore verrebbe immediatamente infranto. Nel podcast in esame tali derive sono state evitate mantenendo un tono rispettoso e verosimile, ma resta il fatto che lo spettatore deve fidarsi degli autori e dell’AI senza poter conoscere in maniera diretta il materiale selezionato per la fase di training. Questo solleva una questione epistemologica non trascurabile: quale è lo statuto di verità di queste memorie vive? Esse non “ricordano” esattamente come farebbe il personaggio originale, ma piuttosto ricordano per conto del personaggio, ricostruendo in modo mediato e contemporaneo la sua possibile prospettiva. Di conseguenza, l’esperienza offerta da VisionnAIres è affascinante, ma richiede un ascolto critico, consapevole dei limiti intrinseci della ricostruzione algoritmica.
| Episodio | Personaggio
AI |
Tema Centrale | Valore implicito
dominante |
Tono della
voce |
Esplicitazione delle fonti per il training |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Asimov | Etica dell’AI e immaginazione | Razionalità e Umanesimo | Logico, pacato | X |
| 2 | Henry Ford | Automazione e produttività | Pragmatismo ed efficienza | Assertivo | X |
| 3 | Marie Curie | Ricerca scientifica ed etica | Responsabilità e metodo | Ispiratorio,sobrio | X |
| 4 | Niccolò Machiavelli | Politica e tecnologia | Realismo e controllo | Affilato, ironico | X |
| 5 | Sherlock Holmes* | Metodo investigativo | Deduzione e razionalità | Analitico | X |
| 6 | Charles Darwin | Evoluzione e sostenibilità (Blue Economy) | Osservazione e adattamento | Riflessivo | X |
Tab. 2: Riepilogo comparativo dei sei episodi analizzati, con indicazione dei temi, dei valori impliciti, del tono vocale e del livello di trasparenza editoriale percepita.
Discussione
L’analisi qualitativa di VisionnAIres evidenzia come il passaggio dalla semplice generazione testuale alla sintesi vocale introduca una serie di implicazioni inedite. In altre parole, qualcosa cambia radicalmente quando i modelli linguistici non operano più solo come generatori di testo, ma assumono voce. Nel nostro caso, i LLMs non si limitano a produrre risposte scritte: si incarnano vocalmente in living memories, ovvero in presenze sintetiche che dialogano con il presente attraverso parole, intonazioni e pause. Le voci di Asimov, Machiavelli, Curie e degli altri intervistati non sono semplici repliche digitali: funzionano come dispositivi narrativi che performano la memoria in modo relazionale, affettivo, immersivo. La voce sintetica, in questo contesto, non va intesa come mero output tecnico, bensì come una vera e propria interfaccia semiotica. Il modo in cui è costruita – il timbro, la velocità di eloquio, le inflessioni e persino i silenzi – influisce direttamente sulla percezione dell’“umano” nell’agente artificiale, generando quella che potremmo definire presenza computazionale. Anche quando l’ascoltatore è pienamente consapevole dell’origine artificiale dell’interlocutore, la voce tende a generare una sensazione di familiarità e fiducia: suona come qualcosa che già conosciamo, anche se, in realtà, non l’abbiamo mai udita prima da quella fonte. È proprio in questa ambiguità tra verosimiglianza e simulazione che risiede gran parte della forza (ma anche della fragilità) della memoria generata dall’AI. Da un lato, la somiglianza convincente con una possibile voce del passato rende vivo il dialogo e coinvolge emotivamente; dall’altro, basta poco, nello specifico un’espressione fuori registro, un’informazione sbagliata, per giungere allo “squarcio nel velo di Maya”, ovvero la rottura dell’illusione e il disvelamento del simulacro.
Il concetto di living memory proposto da Pataranutaporn[10] trova in queste interviste una concreta applicazione, ma al tempo stesso invita a una riflessione critica. Le living memories non sono infatti un mero espediente spettacolare: rappresentano una soglia tra archivio e performance, tra documento e messa in scena, tra dato storico e racconto contemporaneo. Non possiamo considerare queste rievocazioni alla stregua di fonti storiche autentiche, poiché esse non restituiscono il passato “così com’era”, bensì lo reinterpretano in funzione del presente. Ciò non ne sminuisce il valore educativo o divulgativo, ma richiede una consapevolezza epistemologica: siamo di fronte a narrazioni storiche simulate, che possono ispirare e far riflettere, purché non vengano confuse con un accesso diretto alla verità storica. In questo senso, definire la voce AI come interfaccia di memoria culturale appare particolarmente calzante: essa media tra ciò che è stato e ciò che è, mettendo in comunicazione temporalità differenti, ma la mediazione implica sempre una trasformazione del contenuto.
Un ulteriore aspetto critico riguarda la costruzione della presenza vocale sintetica. Nel podcast, come visto, le voci sono create ex novo per evocare personaggi privi di registrazioni audio originali (Machiavelli, Curie, Darwin, ecc.), oppure per richiamare figure di cui esistono testimonianze vocali (ad esempio Asimov) senza però riprodurle fedelmente. Il risultato è efficace in termini narrativi, ma apre scenari di ricerca futuri: sarebbe interessante sperimentare, per quelle figure di cui disponiamo di audio d’epoca, l’impiego di tecniche di voice cloning che replichino timbro e inflessioni originali. Ciò porrebbe nuove domande etiche (è giusto far “rivivere” la voce reale di qualcuno? con quale licenza d’uso della sua identità vocale?) ma potrebbe aumentare ulteriormente il senso di autenticità percepita. In mancanza di ciò, VisionnAIres ha comunque dimostrato che una voce sintetica ben progettata può ottenere il duplice effetto di intrattenere ed educare, senza risultare fredda o meccanica. Possiamo definire questa presenza vocale una forma di doppio digitale controllato: un artefatto sonoro che, da un lato, incarna le conoscenze storiche, dall’altro rimane sotto la guida del team di progettazione che ne ha programmato risposte e comportamenti.
In sintesi, la discussione dei risultati suggerisce che le voci AI applicate al patrimonio culturale possiedono un enorme potenziale come strumenti didattici e museali, capaci di dare nuova vita a saperi storici attraverso l’interattività. Tuttavia, perché queste living memories possano davvero arricchire la memoria collettiva senza distorcerla, è necessario inquadrarle con occhio critico e responsabile. Occorre cioè riconoscerne la natura ibrida, ovvero l’essenza contemporanea di metà archivio e metà finzione, e governarne sia la dimensione tecnica che quella narrativa con approcci multidisciplinari (coinvolgendo informatici, storici, filosofi, esperti di comunicazione) capaci di garantirne l’accuratezza e la fruibilità etica.
Nel complesso, VisionnAIres si presenta come un caso emblematico di quella che potremmo definire memoria computazionale situata: una forma emergente di narrazione che si affida alla plasticità degli agenti AI per evocare il passato secondo logiche attuali di accessibilità, empatia e spettacolarizzazione. Tuttavia, il fascino di queste living memories sintetiche non può essere disgiunto da una riflessione sul loro statuto epistemologico e sul tipo di orizzonte culturale che contribuiscono a costruire.
La memoria, in quanto oggetto tecnicamente mediatizzato, non è mai neutra: è selezione, omissione, messa in scena. Quando a compierla è un’intelligenza artificiale addestrata secondo criteri spesso opachi, la questione si fa ancora più delicata. Ci troviamo di fronte a narrazioni che producono un effetto di autenticità senza che sia possibile verificarne l’origine, e che perciò riformulano implicitamente il concetto stesso di verità storica. In questo senso, il podcast non è soltanto uno strumento comunicativo innovativo, ma una soglia culturale attraverso cui interrogare la ridefinizione post-digitale della memoria collettiva.
È a partire da questa ambivalenza – tra funzione divulgativa e rischio di semplificazione, tra effetto di presenza e costruzione simulata – che si rende necessario un ripensamento teorico più ampio del ruolo delle tecnologie vocali nell’umanesimo digitale contemporaneo.
Conclusioni
L’analisi del podcast VisionnAIres – Interviste (im)possibili offre uno spunto per ripensare in profondità le forme contemporanee della memoria culturale nell’epoca dell’intelligenza artificiale generativa. Attraverso la costruzione di voci sintetiche che impersonano figure storiche, il podcast non si limita a proporre contenuti divulgativi: mette in scena una trasformazione del regime di veridizione della memoria, in cui l’autenticità non è più fondata sulla testimonianza diretta o sul documento, ma sull’efficacia immersiva della simulazione algoritmica.
La voce sintetica, in questo contesto, si configura come un dispositivo transmediale che agisce tanto sul piano affettivo quanto su quello epistemico. Essa produce una forma di presenza computazionale che non rappresenta il passato, ma lo ri-performa secondo logiche compatibili con il presente: esigenze di storytelling, riconoscibilità narrativa, empatia dell’ascoltatore. Il risultato è una memoria culturalmente mediata, che solleva interrogativi sul ruolo dell’AI come attore non neutro nella costruzione delle nostre storie comuni.
Lungi dal rappresentare una semplice innovazione tecnologica, questi artefatti vocali si collocano nel cuore di una tensione più ampia tra archivio e performance, storiografia e fiction algoritmica, verità storica e verosimiglianza emotiva. Il loro impatto va dunque letto all’interno di un orizzonte in cui la memoria non è più solo oggetto da conservare, ma campo di forze, interfaccia dinamica tra passato e presente, tra umano e post-umano.
Più che proporre linee guida normative, questo lavoro intende sollevare una domanda aperta e radicale: quale tipo di memoria collettiva stiamo costruendo quando affidiamo la voce del passato agli algoritmi del presente? In che modo queste nuove forme di “memoria vivente” ridisegnano l’orizzonte stesso dell’umano, del sapere e del ricordo? È in questa soglia teorica, ancora instabile, che si gioca la posta in gioco di un Umanesimo Tecnologico non solo capace di adottare strumenti digitali, ma di criticarli dall’interno, mettendo in discussione le condizioni della loro legittimità culturale.
Bibliografia
P. Connerton, How Societies Remember, Cambridge University Press, Cambridge 1989.
K. Crawford, Atlas of AI. Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence, Yale University Press, New Haven 2021.
M. Halbwachs, La mémoire collective, PUF, Parigi 1950.
A. Hoskins, Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective Turn, Routledge, Londra 2011, pp. 19-31.
H. Jiang et al., PersonaLLM: Investigating the Ability of Large Language Models to Express Personality Traits, «Findings of the Association for Computational Linguistics: NAACL 2024», pp. 3605–3627.
C. Jones – B. Bergen, Large Language Models Pass the Turing Test, in «arXiv preprint», 2025. https://osf.io/jk7bw (consultato il 7 marzo 2025).
N. Pataranutaporn et al., Living Memories: AI-generated Characters as Digital Mementos, «Proceedings of the 28th International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI ’23)», ACM, New York 2023, pp. 889–900.
H. L. Roediger III, Memory Metaphors in Cognitive Psychology, «Memory & Cognition», VIII, 3, 1980, pp. 231–246.
VisionnAires, progetto. https://www.unibocconi.it/it/entrare-bocconi/corsi-di-laurea-magistrale/orientamento-ai-corsi-di-laurea-magistrale/visionnaires-ai-generation (consultato il 7 marzo 2025).
Benedetto Bramante
(PhD in sociologia dei media – focus su Intelligenza Artificiale e comunicazione museale – dell’Università di Ferrara)
Francesca Bignotti
(Studentessa magistrale di Storia delle Arti all’Università di Verona)